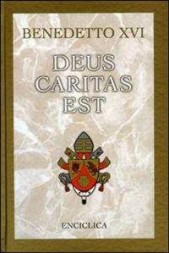“Deus caritas est”: Trinità e vita individuale e sociale
Sacerdos, edizione italiana, Anno XII n. 61, Maggio-Giugno 2007
don Pietro Cantoni
Di solito la prima enciclica di un papa ha un carattere “programmatico”: pensiamo ad esempio alla “E supremi apostolatus cathedra” di san Pio X (4 ottobre 1903) o alla “Redemptor hominis” di Giovanni Paolo II (4 marzo 1979). Con la “Deus caritas est”, la prima e finora unica enciclica di Benedetto XVI (25 dicembre 2005), ci troviamo quindi di fronte al programma di un pontificato. Si sente già nell’aria (e forse anche nel cuore…) la solita obiezione: “Ma con tutti i problemi che ci sono! Andare a parlare della Trinità…”. Perché è della Trinità che qui si parla, in ossequio all’assioma agostiniano: ” Se vedi la carità, vedi la Trinità [vides Trinitatem, si caritatem vides] ” (Sant’Agostino, De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287), citato al n. 19.
Con tutti i problemi che ci sono… parliamo piuttosto di cose concrete! Si racconta che un Vescovo dopo aver ascoltato le lamentele e i problemi di un sacerdote, lo consolava richiamandogli gli splendori del mistero della santissima Trinità. E quello di rimando: “Ma che Trinità e Trinità d’Egitto, parliamo di cose serie…”.
La vicenda del mistero della Trinità nel nostro Occidente è stata quella di un progressivo oblío, non evidentemente nella fede viva e profonda della Chiesa, ma certamente nella consapevolezza della sua effettiva importanza, soprattutto sociale. Anche in questo caso Immanuel Kant ha giocato un ruolo decisivo; nella sua opera significativamente intitolata La religione nei limiti della sola ragione (1793) afferma che “Dalla dottrina della Trinità […] non si può semplicemente trarre alcuna conseguenza per la vita pratica, anche se si credesse di comprenderla immediatamente; ancora molto meno però quando uno si convince che supera i nostri concetti”. Che in Dio ci siano tre o dieci persone ha poca importanza, perché “da questa differenza non si può trarre nessuna regola diversa per il proprio comportamento”. Questa mentalità razionalistica, che ha finito per permeare tutta la vita culturale della società occidentale, non poteva non esercitare il suo influsso anche sulla predicazione degli uomini di Chiesa. In molti casi ci si riduceva a parlare della Trinità in occasione della festa corrispondente, in cui spesso ci si toglieva d’impaccio raccontando la famosa leggenda di sant’Agostino che passeggia sulle rive del mare rimuginando il mistero della Trinità e incontra un bimbo che si sforza di riempire un buco scavato nella sabbia versandovi l’acqua del mare con una conchiglia: “voglio mettere il mare in questo buco”… Il santo Dottore si mette a ridere, ma il riso si spegne sulle sue labbra quando il bimbo soggiunge – prima di scomparire – “come tu vuoi fare entrare il mistero della Trinità nel tuo intelletto”. Il messaggio era chiaro: lasciamo il mistero nella sua misteriosità fino alla prossima festa.
Ora però, per altra via, il mistero della Trinità ritorna a rivestire il ruolo che è suo proprio, quello cioè di ultima e decisiva discriminante della fede cristiana. Il confronto sempre più stretto con un’altra religione mondiale, l’Islam, con cui condividiamo l’adorazione di un “unico Dio” (Nostra Ætate, n. 3), costringe il cristiano ad interrogarsi sul perché dalla fede nello stesso Dio discendano conseguenze così diverse a livello morale individuale e sociale… L’unica risposta possibile è che, se Dio è lo stesso in quanto termine degli atti di adorazione e di lode, non è però conosciuto nello stesso modo e l’accettazione o il rifiuto della sua intima vita trinitaria non costituiscono un elemento secondario e accidentale, ma determina tutto un modo diverso di intendere la religione e la vita. “Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 234).
Il Papa si avventura quindi con passo deciso a parlare della Trinità e introduce il discorso, ovviamente, cercando di chiarire la realtà dell’amore, posto che è vedendo questo che si vede anche quella. Osserva che il mondo greco conosceva diversi termini per indicare l’amore. Il più usato era certamente eros, mentre a margine troviamo anche agape. “l’Antico Testamento greco usa solo due volte la parola eros, mentre il Nuovo Testamento non la usa mai: delle tre parole greche relative all’amore — eros, philia (amore di amicizia) e agape — gli scritti neotestamentari privilegiano l’ultima, che nel linguaggio greco era piuttosto messa ai margini” (n. 3). Questo slittamento terminologico ha un significato difficilmente sopravvalutabile. Il passaggio da eros a agape – un passaggio che non deve essere assolutamente interpretato in chiave dialettica, ma piuttosto nel senso del compimento – descrive non solo il darsi della Rivelazione divina su un punto centrale riguardante insieme la natura profonda di Dio e il senso ultimo della vita umana, ma anche – appunto – l’itinerario ideale dell’amore umano. Eros trova nell’agape il suo senso e il suo compimento. Ma che cosa è l’eros? Nel linguaggio della mitologia greca: chi è Eros? A questa domanda risponde Platone nel dialogo Simposio. Eros secondo Platone non è un dio ma un démone, cioè un essere intermediario tra il mondo degli dei e quello degli uomini. Afrodite dà un banchetto a cui invita tutti gli dei, tra i quali anche Poros (il mercantile “ingegno” o “espediente”). Penìa (la povertà) sta alla porta a chiedere, secondo il suo solito, l’elemosina. Poros approfitta del vino buono e abbondante e finisce per addormentarsi ubriaco nel giardino di Zeus, alle soglie della sala del banchetto. Penìa, che nella sua miseria cerca una discendenza, si unisce a lui e concepisce Eros. Eros è dunque figlio di “povertà” ed “espediente”. Povertà perché cerca appassionatamente quello che gli manca, “espediente” perché è ingegnoso e insonne in questa ricerca. Non è, né può essere dio, perché è mancante, ma non è neppure un mortale, perché non finisce mai. È un démone “mediatore”, appunto.
La concezione dell’amore come eros, cioè come ricerca di ciò che manca, precludeva però alla filosofia antica la possibilità di porre l’amore in Dio: Dio infatti – per definizione – non manca di nulla… È per questo che Aristotele concependo Dio come “motore immobile”, cioè come principio di movimento e di vita non sottoposto a sua volta al movimento, lo fa principio dinamico come causa finale, come oggetto di desiderio e di amore: “muove come ciò che è amato (kineî dè hos erómenon)” (Metafisica XII, 7). Dio quindi non ama, né può amare nessuno: è tutto il resto del mondo che lo ama e a lui irresistibilmente tende…
La rivelazione cristiana approfondisce la realtà dell’amore nel senso dell’agape, cioè dell’amore di amicizia che è soprattutto dono. In questa luce non risulta più contraddittorio porre l’amore in Dio, anzi addirittura identificare Dio con l’amore: “Dio è amore – ho Theòs agápe estín – Deus caritas est” (1 Gv 4,8.16). È questa una delle affermazioni centrali del Nuovo Testamento, paragonabile solo alla rivelazione del nome di Dio in Es 3,14: se nell’Antico Testamento Dio è identificato con l’essere nella sua pienezza e perfezione (Io sono), nel Nuovo la natura profonda dell’Essere misterioso di Dio si svela come Amore. Sapere che Dio non soltanto ama, ma è Amore nella sua intima essenza non può non avere conseguenze sulla vita individuale e sociale di chi almeno si sforza di vivere in conformità con questa fede. Non solo ma, posto che l’uomo non è una creatura di Dio come le altre, ma lui solo è stato creato a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen 1,26), questo ha conseguenze inaudite sul concetto che l’uomo è destinato a farsi di sé e dei suoi simili.
Questa riflessione si apre naturalmente sulla seconda parte dell’enciclica, intitolata “Caritas – L’esercizio dell’amore da parte della Chiesa quale “comunità d’Amore””. Il legame tra le due parti è evidente da più punti di vista. Proprio nell’introduzione Benedetto XVI, in continuità con Giovanni Paolo II, ha ri-sottolineato un aspetto fondamentale della fede cristiana che la distingue nettamente da qualunque ideologia: ” All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva ” (n. 1). Non è – ovviamente – un’idea nuova: chi conosce gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola sa che con la prima contemplazione della seconda settimana, il famoso esercizio della “Chiamata del Re”, Ignazio ripropone a fondamento della vita cristiana non più un insieme di verità dottrinali, ma il rapporto con una Persona, la Persona del Verbo incarnato, Signore di tutte le cose, degli uomini, delle società e della storia. Questo conferisce al cristianesimo un “realismo inaudito” (n. 12), la sua vera novità infatti “non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti” (Ibidem). Questo incontro con Gesù avviene principalmente nel sacramento dell’Eucaristia, dove però ” Noi non riceviamo soltanto in modo statico il Logos incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione” (n. 13). Qui appare chiaro come Dio ci fa del bene, facendoci fare del bene… Nel momento infatti in cui ci dona il massimo dei beni, cioè sé stesso, ci attira nel suo amore. Ecco allora che la carità non è un’espressione tra tante della Chiesa che nasce dall’Eucaristia, ma la sua espressione propria. Anche se non dobbiamo ridurre l’esercizio dell’amore al solo sollievo delle esigenze materiali, perché “L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro” (n. 25). Tutti e tre questi “compiti” sono esercizio dell’amore di Dio donato alla Chiesa e che lei riversa sul mondo. Tuttavia prende un particolare risalto in questa prospettiva la “diaconia” come esercizio della carità nei confronti di tutti i sofferenti e bisognosi che essa incontra nel mondo.
Questo esercizio della carità è dunque un compito proprio della Chiesa, che essa si assume in prima persona, conferendogli anche la sua specificità. Il modo di far carità della Chiesa non può e non deve dissolversi in una generica solidarietà umana: “La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza” (n. 25). Davanti ad esso e contro di esso si erge un’obiezione che proviene dall’ideologia marxista: “I poveri, si dice, non avrebbero bisogno di opere di carità, bensì di giustizia. Le opere di carità — le elemosine — in realtà sarebbero, per i ricchi, un modo di sottrarsi all’instaurazione della giustizia e di acquietare la coscienza, conservando le proprie posizioni e frodando i poveri nei loro diritti. Invece di contribuire attraverso singole opere di carità al mantenimento delle condizioni esistenti, occorrerebbe creare un giusto ordine, nel quale tutti ricevano la loro parte dei beni del mondo e quindi non abbiano più bisogno delle opere di carità” (n. 26); “chi in una situazione di potere ingiusto […] aiuta l’uomo con iniziative di carità, si pone di fatto a servizio di quel sistema di ingiustizia, facendolo apparire, almeno fino a un certo punto, sopportabile. Viene così frenato il potenziale rivoluzionario e quindi bloccato il rivolgimento verso un mondo migliore” (n. 31). Quest’obiezione nasce da una “filosofia disumana” che interpreta l’uomo in chiave materialistica e misconosce la sua intrinseca ordinazione al trascendente. Certamente è vero che la società deve essere giusta e che compito specifico della politica è quello di produrre un continuo sforzo perché nella società le strutture siano improntate il più possibile alla giustizia. Impegnarsi in questa azione politica è compito proprio del cristiano laico, per il cui svolgimento la Chiesa fornisce strumenti specifici: una Dottrina sociale che mira alla “purificazione della ragione” (n. 29) e una formazione etica tesa “al risveglio delle forze morali” (n. 29). Il cristiano è infatti ben consapevole che un reale cambiamento non può essere frutto di pura dottrina, ma è questione di vita virtuosa e che anche le virtù morali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) traggono dalla grazia e dalle virtù teologali un impulso concretamente indispensabile. La “Dottrina sociale”, che si è andata sviluppando nel corso dei secoli, in modo particolare a partire dallo scoppio della questione sociale nel secolo diciannovesimo, ” argomenta a partire dalla ragione e dal diritto naturale, cioè a partire da ciò che è conforme alla natura di ogni essere umano” (n. 28). Mentre la Chiesa si assume in proprio l’esercizio della carità verso i bisognosi, non fa lo stesso quanto all’ impegno di far valere politicamente la sua dottrina sociale, perché questo è il compito specifico dei fedeli laici. Un compito che però rientra anch’esso, a modo suo, nell’esercizio della carità, come “carità sociale” (n. 29).
Dev’essere però chiaro che il fine da perseguire è quello di operare “caritatevolmente” per la giustizia e quindi di far sì che ci siano le giuste condizioni in cui l’esercizio volontario e libero della carità – sia in forma individuale che collettiva – possa avvenire senza ostacoli, anzi con opportuni incentivi e favori, non quello – disumano e utopistico – di voler rendere inutile la carità mediante l’intervento soffocante delle burocrazie statali. “L’amore — caritas — sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. Non c’è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé, diventa in definitiva un’istanza burocratica che non può assicurare l’essenziale di cui l’uomo sofferente — ogni uomo — ha bisogno: l’amorevole dedizione personale. Non uno Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci occorre, ma invece uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto. La Chiesa è una di queste forze vive: in essa pulsa la dinamica dell’amore suscitato dallo Spirito di Cristo. Questo amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell’anima, un aiuto spesso più necessario del sostegno materiale”.
 Opus Mariae Matris Ecclesiae
Opus Mariae Matris Ecclesiae